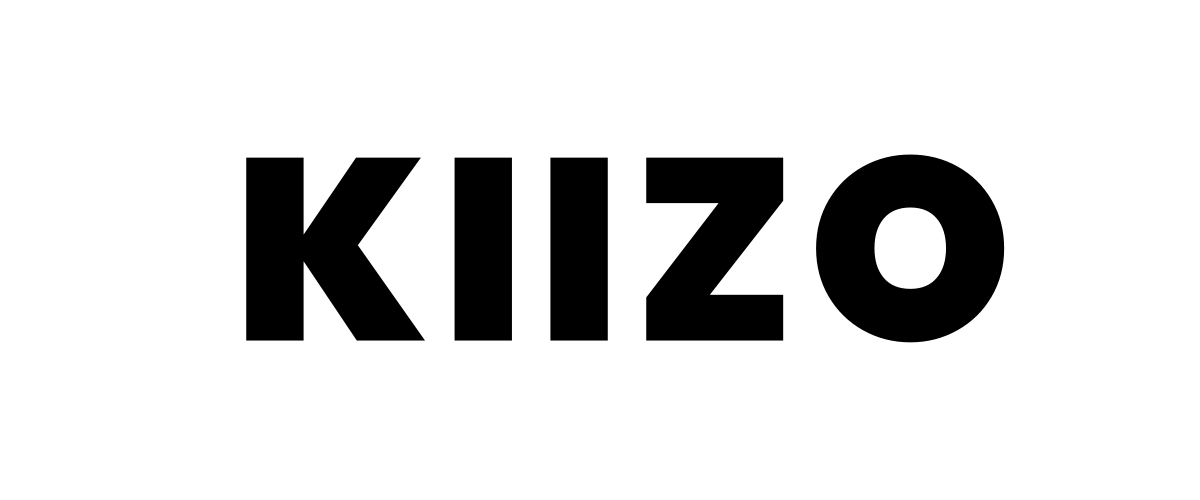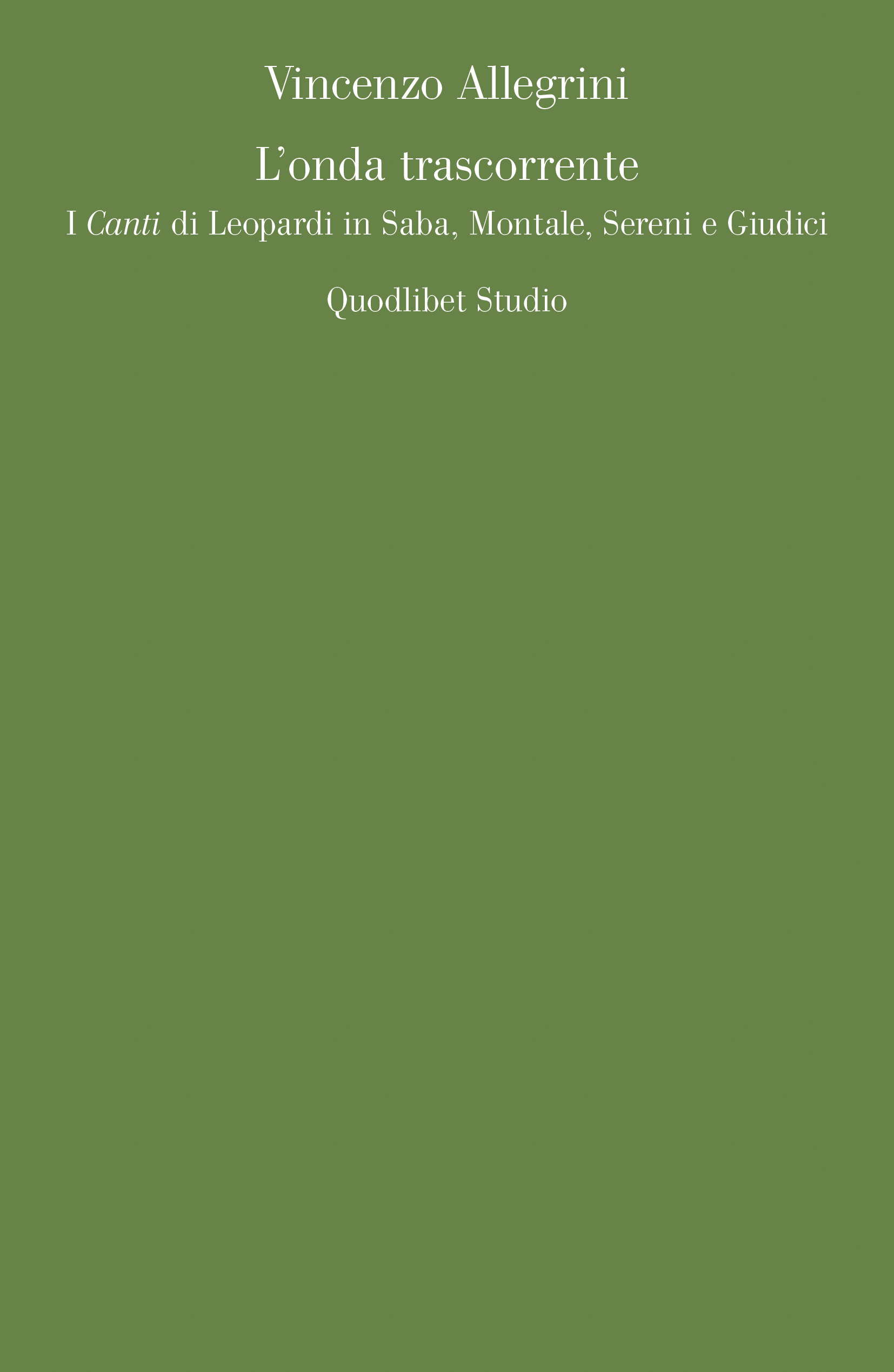Description
Questo libro insegue le tracce di Leopardi nelle opere di Saba, Montale, Sereni e Giudici. Un'ampia campionatura, dunque, che dagli interventi critici e dagli scritti autoesegetici si estende alla produzione in
versi, illustrando di volta in volta i punti d'incontro (o scontro) con il
pensiero e la poesia di Leopardi.
L'allusione, la polemica, la parodia, le riprese metrico-sintattiche, le
citazioni esplicite, nascoste o dissimulate sono le più prevedibili modalità di confronto con il grande poeta ottocentesco. A esse, però,
s'affianca qui una costante attenzione al ricorrere di immagini care a
Giacomo: le chiuse imposte del Sogno, la mano del finale di A Silvia,
l'errar del tuono tra i crinali del Canto notturno, le rive scintillanti
della Ginestra. D'altra parte, altrettanto di frequente ritornano – in
forme sempre diverse – alcune tra le più celebri figure dei Canti, che
siano umane (Silvia, Nerina, Aspasia), divine (le ninfe, le Erinni, Diana), animali (il passero, la greggia) o naturali (la luna, una nuvola che
si dilegua e una foglia che cade).
Ma nelle liriche dei quattro poeti l'influsso dei Canti non emerge solo
in superficie. Il libro leopardiano agisce infatti nel profondo mediante
un fitto, e a volte intricato, sostrato comune di topoi: la morte giovanile e innocente, il canto udito da lungi, lo stormire del vento, l'addio
prematuro alla giovinezza, il ritorno al borgo natio, le favole antiche
della Primavera, l'attesa vana del dì festivo, la fratellanza tra Amore e
Morte e altro ancora. Accanto ai topoi, infine, vi sono i mitologemi.
Su tutti, quello della fanciulla germoglio, la Silvia-Persefone: il vero fil
rouge o, per riprendere una formula di Saba, il «filo d'oro» di queste
pagine. È così che l'«onda trascorrente» dei Canti – stavolta l'immagine è sereniana – dà e trova nuova linfa nella poesia di quattro protagonisti assoluti del primo e secondo Novecento italiano.